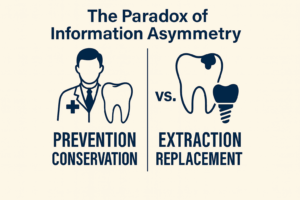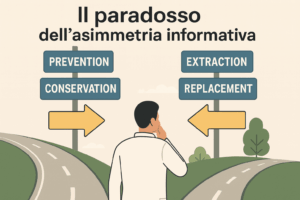Nel 1978 Herbert Simon vinse il Premio Nobel proprio grazie a questo concetto, che ogni giorno vivo sulla mia pelle.
La parola — coniata negli anni ’50 — combina “satisfy” (soddisfare) e “suffice” (essere sufficiente). Simon la usava per descrivere il modo in cui prendiamo decisioni in contesti complessi, contrapponendola all’idea di “massimizzare”, ovvero cercare sempre la soluzione ideale.
Secondo Simon, molti problemi reali sono caratterizzati da intrattabilità computazionale (troppe variabili difficili da quantificare) o da mancanza di informazioni che rende impossibile utilizzare procedure matematiche o rigidamente razionali. E allora? Abbiamo due strade: cercare soluzioni ottimali in un mondo semplificato, oppure soluzioni sufficientemente buone in un mondo reale.
I due approcci convivono nelle scienze gestionali. Ma il primo — quello che semplifica la realtà in modelli logici — è anche quello più pericoloso: genera spesso effetti collaterali devastanti.
La crisi dei subprime del 2008 è l’esempio perfetto. L’applicazione cieca di modelli matematici su un mercato immobiliare artificialmente semplificato ha creato un gigantesco castello di carte, crollato con il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008.
Simon criticava apertamente l’educazione tradizionale, che insegnava a prendere decisioni solo in condizioni di perfetta certezza.
Per lo stesso motivo, sorrido quando vedo studi implantari costruiti su pazienti ideali: estrazioni eseguite almeno sei mesi prima, nessuna parafunzione, nessuna malattia parodontale, non fumatori, nessun problema sistemico, igiene orale impeccabile. Ottimi numeri, certo. Ma che utilità hanno, se quel tipo di paziente rappresenta appena il 10% della nostra realtà quotidiana?
E cosa dire degli studi in vitro, in condizioni perfettamente controllate, che pretendono poi di essere applicati senza filtri nella clinica reale?
O del circo congressuale, dove ogni relatore mostra dati perfetti, slide impeccabili, casi clinici in cui nulla va mai storto?
Nessun impianto fallisce. Nessuna complicanza. Tutte le endodonzie raggiungono apici perfetti. I restauri sembrano superare madre natura. Tutto, magicamente, funziona.
La maggior parte dei pazienti implantari reali sono invece pazienti parodontali.
La maggior parte dei pazienti non comprende davvero il valore della prevenzione.
Farli aderire a programmi di mantenimento è un lavorone quotidiano.
La maggior parte dei pazienti non ha strumenti per valutare realmente la qualità dei nostri trattamenti.
E sempre più spesso, ha anche limiti economici concreti.
Tutto questo, però, scompare appena usciamo dai nostri studi.
Nessuno vuole parlare delle complicanze quotidiane, dei pazienti meno che ideali con cui lottiamo ogni giorno.
La realtà viene negata nei weekend di aggiornamento, di fronte a slide sempre più curate: la diga stesa senza una piega, perfettamente invaginata nel solco, mai una lacerazione, mai una traccia di sporco.
Simulacri di perfezione, dominio dell’uomo sulla natura.
Ma la realtà bussa di nuovo alla porta ogni lunedì mattina.Ecco perché, negli ultimi vent’anni, ho cambiato il mio modo di vivere l’odontoiatria:
non inseguendo più una perfezione teorica, ma cercando soluzioni praticabili ogni giorno.
Non è eccellenza accademica: è un’odontoiatria “satisficing”.
E sono certo che Herbert Simon approverebbe.
👉 Se anche tu credi che l’odontoiatria reale debba essere al centro della formazione, ti aspetto al Injectable Restorations European Summit, il 7-8 novembre a Milano.
Due giorni di tecniche concrete, problemi veri, pazienti veri.
Niente vetrine, niente effetti speciali: solo clinica quotidiana, come quella che affrontiamo ogni lunedì.